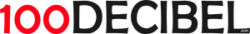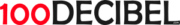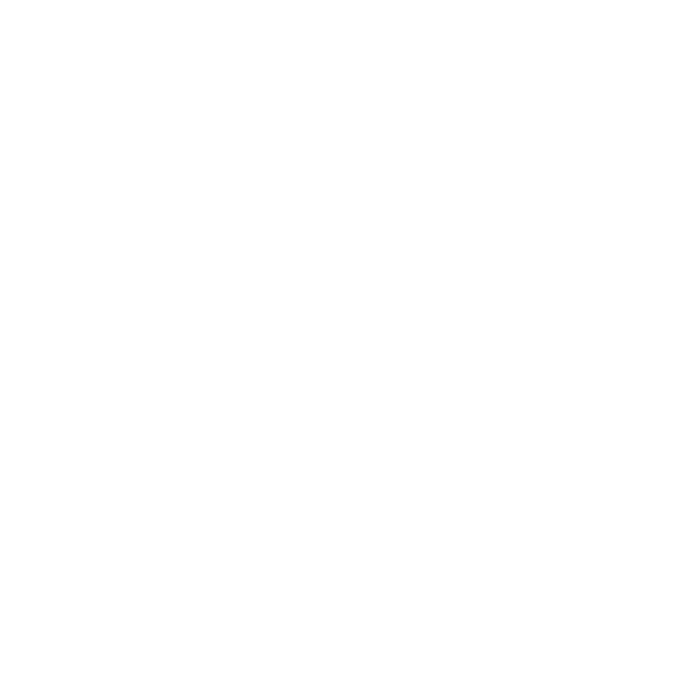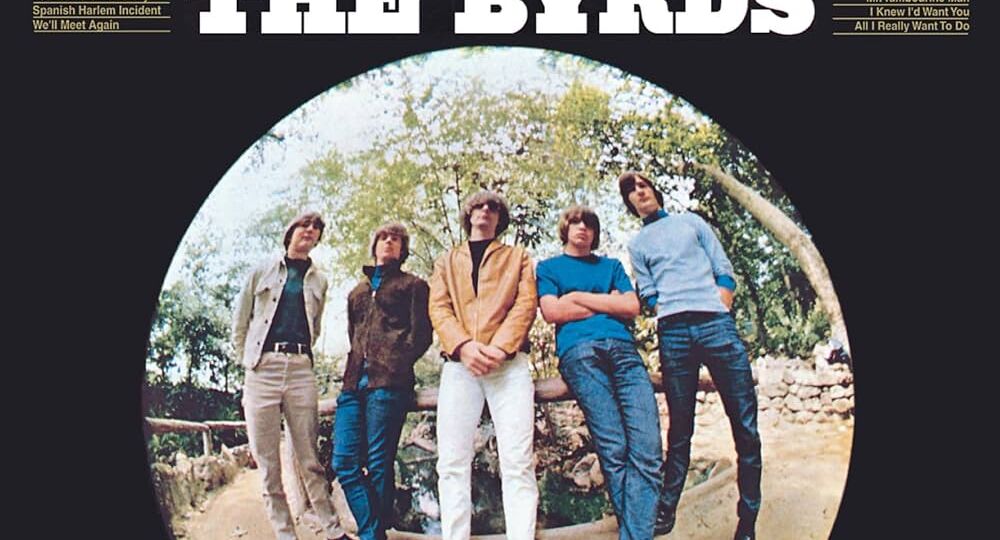Con “Occidente, a Funeral Party”, i DISH-IS-NEIN mettono in scena il funerale di un’idea: quella di un’Occidente capace di evolversi e rigenerarsi. Il disco è un viaggio lucido e implacabile tra le rovine di una società che ha tradito sé stessa, soffocando sotto il peso delle proprie contraddizioni.
Attraverso otto brani intensi e corrosivi, la band racconta la fine degli ideali di progresso, inclusività e libertà, svuotati di senso dal consumismo, dalla sorveglianza permanente e dall’ipocrisia mediatica.
Non c’è spazio per la redenzione: la modernità è vista come un disastro annunciato, una festa macabra dove l’indifferenza è la regola e la disillusione l’unica certezza.
“Occidente, a Funeral Party” è il grido di chi sceglie di non scegliere, rifiutando verità prefabbricate e menzogne di comodo. Un’opera dura, necessaria, che non cerca consolazione ma pretende consapevolezza.

“Occidente, a Funeral Party” è un disco che si fa portavoce di un presente in rovina. Qual è stato il punto di rottura che vi ha spinto a tornare con questo nuovo lavoro discografico?
Ciao, prima di tutto lascia che ti ringrazi per lo spazio che 100 Decibel dà al progetto Dish-Is-Nein. Venendo alla tua domanda, credo che vada “scissa” in due parti. “Il punto di rottura”, come lo hai chiamato tu, sta alla base del concept su cui è nato questo lavoro. Si tratta in primis di uno stato d’animo; sentirsi del tutto estranei al mondo che ti circonda, all’ambiente in cui sei cresciuto ma nel quale non ti ritrovi più. Una civiltà letteralmente in pezzi. I valori in crisi sono morti sepolti e in decomposizione. Ho un’immagine che spesso mi capita di abbinare a questi tempi bui: una scena tratta dal “Nosferatu” di Herzog che mostra una Venezia dilaniata dalla peste, con carcasse sparse ovunque. In tutto questo immane disastro, ci sono alcuni nobili morenti che banchettano allegramente circondati da topi, che hanno invaso la città, in attesa di cibarsi a loro volta dei cadaveri… non so se ho reso l’idea. La spinta che ci ha fatto decidere di tornare a fare musica è l’amore e la passione che abbiamo e che col tempo, dopo un lungo momento di sofferenza e smarrimento causati dalla scomparsa di Dario, è tornata a riaffiorare. Si trattava di capire se saremmo stati in grado di scrivere in modo credibile e rappresentativo per noi. Non ci siamo posti il problema se i nostri nuovi brani sarebbero piaciuti o meno, non l’abbiamo mai fatto, ma se questi ci avessero rappresentato per le persone che siamo oggi. Dopo aver messo giù i primi provini ci siamo subito resi conto che saremmo riusciti a comporre un nuovo album.
Nel disco avete scelto di non inserire chitarre, trasformando un’assenza in una presenza fortissima. Com’è stato scrivere e arrangiare musica lasciando volutamente un vuoto sonoro?
Il problema, ad essere sinceri, è stato soprattutto di natura emotiva. Con Dario ho condiviso tutte le cose più importanti che ho fatto a livello musicale. Il non averlo più al mio fianco è stato, soprattutto inizialmente, davvero straniante. Da un punto di vista più prettamente artistico/tecnico/musicale, con Roberta abbiamo trovato un equilibrio che ci ha permesso di portare avanti il lavoro in modo efficace e tutto sommato fluido, al netto dei nostri rispettivi impegni “umani” e lavorativi. L’idea, il filo conduttore, è stato quello di dare una forte rilevanza al basso di Roberta ed alla batteria (suonata magnificamente da Justin Bennet), facendoli coesistere con una pesante componente elettronica di stampo noise e glitch. Anche le voci sono state lavorate, a livello di sonorità, per avere una connotazione quasi “strumentale”.
C’è un filo rosso che lega questo lavoro ai capitoli precedenti della vostra storia, dai tempi dei Disciplinatha a oggi? O avete voluto segnare un taglio netto?
Inevitabilmente sì, in quanto ciò che è stato fa parte del nostro background, com’è logico e sano che sia. Questo filo conduttore però è stato soprattutto a livello di imprinting concettuale e di approccio al lavoro più che a riferimenti diretti a sonorità pregresse. Ci sono alcune citazioni a testi presenti in un paio di brani dei “Disci”, ma non solo. A me piace molto lo strumento della citazione, se fatto nel pieno rispetto della fonte e se questa assume poi una forte valenza nel contesto all’interno del quale viene inserita.
Spesso la vostra musica è definita “dissonante”, anche in senso concettuale. Come costruite la tensione sonora per farla diventare messaggio politico?
Questo nuovo lavoro, come in parte anche il precedente, nasce con un concept molto forte (il funerale dell’occidente) e che sta alla base della scrittura sia della musica che dei testi. L’idea, il tentativo, era quello di offrire un’esperienza d’ascolto che fosse la più immersiva possibile, dove musica e testi raccontassero la stessa storia. Dare un certo incipit politico al tuo lavoro, nel momento in cui dici cose che in un modo o nell’altro hanno una forte valenza sul vissuto quotidiano, magari anticipando temi di un futuro prossimo venturo, credo diventi quasi “automatico”, almeno lo è sempre stato per noi.
Pensate che oggi ci sia ancora spazio per un’arte che graffia, che urla, che non chiede permesso? Mah, se devo rapportarmi alla “qualità” media della proposta musicale alternativa (che poi alternativa non lo è per niente) mi verrebbe da dire di no. Poi però penso che siamo sommersi da talmente tanta merda che il rifiuto, la reazione, la rabbia, debbano avere un loro spazio avendo una fortissima ragione d’essere. La verità però è che l’arte, o almeno una larga parte di essa, è profondamente paracula, strumento di propaganda, nel senso che racconta alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire, diventando, nella realtà dei fatti, puro “intrattenimento”, come dice del resto il “nostro” establishment, pacatamente e con sobrietà.