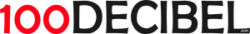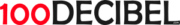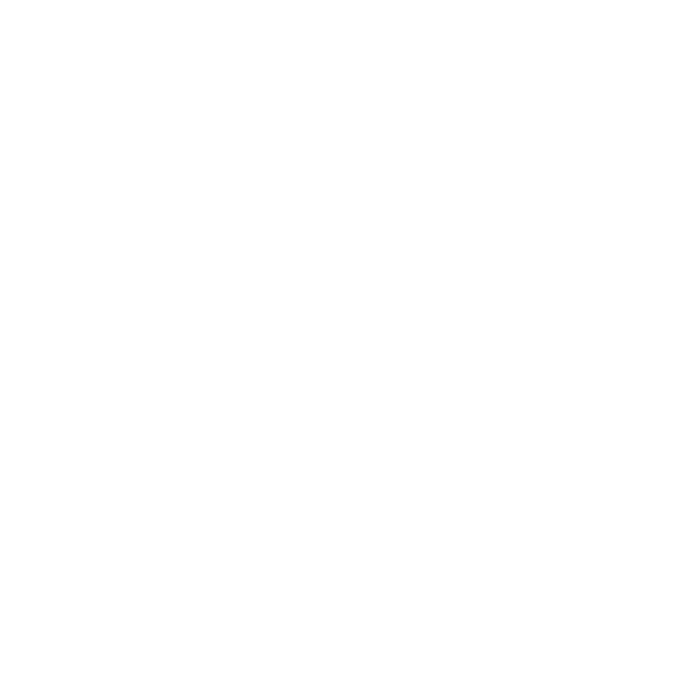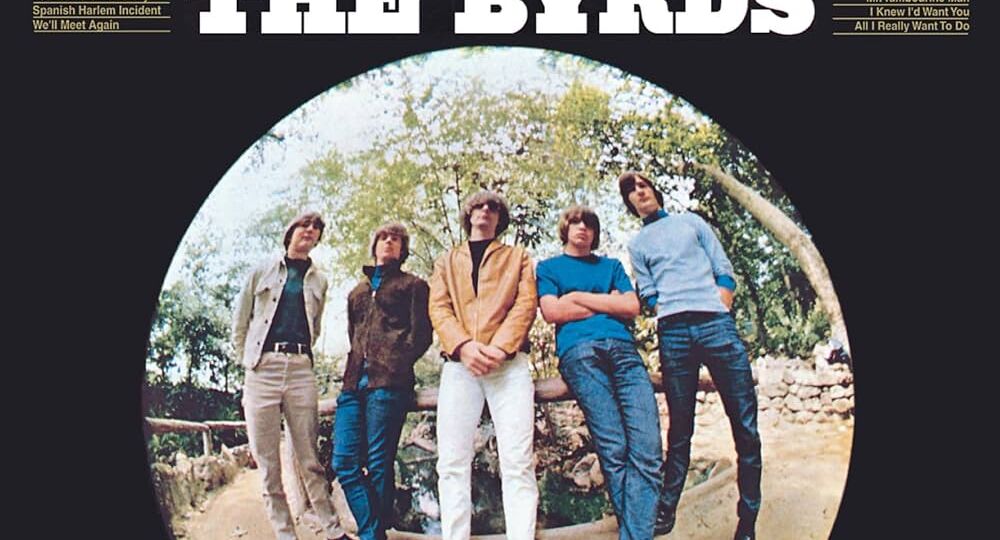Testo: Fabio Babini
Foto: Tommaso Notarangelo
Quando Mark Guiliana sale sul palco del Monk, nell’ambito della rassegna Jazz Evidence, il silenzio ha già preso possesso della sala. Nessuna introduzione, nessun artificio: solo un uomo, una batteria e una piccola costellazione di strumenti elettronici. È un’apparizione minimale eppure densa, quasi rituale, come se ogni elemento fosse stato ridotto all’essenziale per lasciare spazio alla sola verità che conta: la musica. In questa performance solitaria, Guiliana non si limita a eseguire brani. Scolpisce il tempo, disegna paesaggi e attraversa dimensioni sonore con la precisione di un artigiano zen e l’urgenza di un predicatore visionario.
Acclamato dal New York Times come «un batterista attorno al quale si è formata una vera e propria adorazione», l’artista newyorkese ha portato nella capitale italiana l’essenza più pura della sua ultima avventura artistica: ‘MARK’, il suo primo album completamente solista. Non si tratta solo di una raccolta di brani, ma di un diario sonoro, di una mappa emotiva che riflette un percorso personale e artistico sempre più audace. Registrato allo Studio 606 di Los Angeles, questo lavoro è un ibrido vivo, una creatura sfuggente in cui convivono poliritmie tribali, interludi sintetici e frasi melodiche accennate al pianoforte, tutte eseguite e sovrapposte da Guiliana stesso, in un processo di costruzione artigianale tanto meticoloso quanto ispirato.
Al Monk, questo processo è diventato tangibile, col pubblico che ha assistito alla genesi di ogni pezzo in tempo reale: una cassa riverberante che si ripete, un charleston nervoso che entra in scena, poi un sintetizzatore che si insinua come nebbia. Lì, sotto le luci essenziali del club capitolino, il buon Mark ha intrecciato linguaggi disparati – jazz, elettronica, glitch, ambient, spoken word (per la presenza costante di visual o di reali “intromissioni televisive” alle sue spalle – in un set che ha sfidato la classificazione. Non c’è stato spazio per l’ovvio, eppure ogni passaggio sembrava necessario. Il flusso musicale si è snodato senza soluzione di continuità, passando da momenti ipnotici a esplosioni controllate di energia, con un senso della forma che tradiva una visione precisa, anche nei frangenti più liberi.
Non è difficile capire perché Mark Guiliana sia diventato un punto di riferimento per una generazione di musicisti che cerca di espandere i confini del suono. Con una carriera che lo ha visto collaborare con nomi come St. Vincent, Meshell Ndegeocello, M83 e Matt Cameron, e con un posto d’onore accanto a David Bowie in quel suo ultimo tassello cupissimo che è stato ‘Blackstar’, Guiliana incarna una figura d’artista capace di muoversi trasversalmente tra i generi senza mai perdere coerenza. Il suo tocco – chirurgico e lirico al tempo stesso – riesce a comunicare anche quando tutto intorno tace.
Al Monk, questa capacità si è manifestata in modo quasi disarmante. Nei momenti in cui lasciava che una pletora di percussioni disparate tenesse il battito, lui si spostava al piano, cercando accordi che sembravano nascere da un’urgenza intima, personale. In altri istanti, il set si popolava di loop vocali, battiti distorti, armonie liquide: un collage di suggestioni dove il confine tra improvvisazione e composizione risultava sfumato, forse irrilevante. Il pubblico, attento e assorto, ha seguito ogni deviazione, ogni implosione, come ipnotizzato da una narrazione che procedeva per intuizioni più che per temi, fino a partecipare attivamente durante l’esibizione dell’ultimo brano in scaletta, quando il nostro italoamericano ha distribuito sonagli (!) di ogni tipo tra la folla, per poi dirigerla a suo modo mentre si dimenava suonando tra le tastiere e la batteria.
Rispetto ai suoi precedenti lavori su Edition Records – ‘The Sound of Listening’ e ‘Mischief’ – ‘MARK’ segna una svolta decisa verso l’esplorazione individuale: se prima l’interazione con gli altri musicisti era la miccia per innescare il flusso creativo, ora il musicista si erge a compositore sui generis, confrontandosi con la solitudine come spazio creativo. E in quel vuoto trova nuova materia da modellare: il silenzio tra due colpi di rullante, l’attesa che precede un crescendo, l’eco digitale di un sample che svanisce.
Nonostante la complessità del materiale proposto, la performance non è mai diventata sterile o autoreferenziale. Al contrario, c’era una sincerità palpabile in ogni gesto, una trasparenza che raramente si associa a un livello tecnico così elevato, non esibisce la sua bravura, anzi, la mette al servizio di un racconto che non ha bisogno di parole. È questo equilibrio tra umanità e rigore che rende il suo approccio così unico.
Alla fine del concerto, nessun bis ma un saluto sentito e il giocoso dispiacere nel non poter comunicare in italiano, “perché mio padre non me lo ha mai insegnato”. Solo applausi lunghi e sentiti, come un ringraziamento per aver condiviso qualcosa di raro. Mark Guiliana, solo sul palco ma circondato da un’intera costellazione di voci, suoni e intuizioni, ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un batterista. È un esploratore del presente e come detto un vero scultore del ritmo, un autore di visioni. E Roma, per una sera, è stata testimone di questo passaggio.